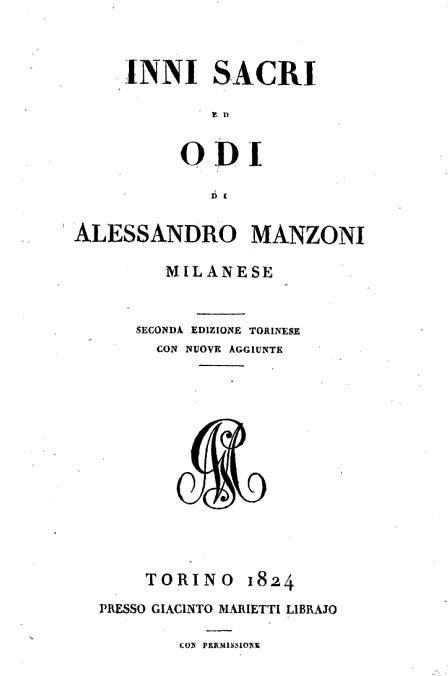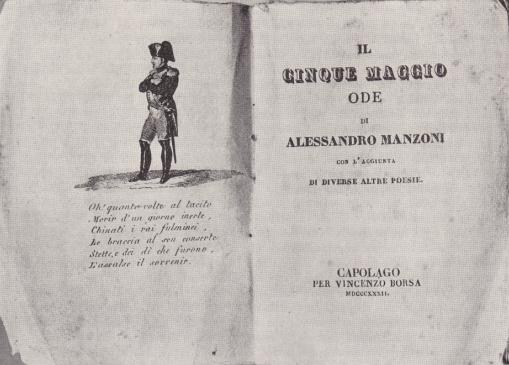CESARE ANGELINI
LA LIRICA MAGGIORE
In C. Angelini, Capitoli sul Manzoni vecchi e nuovi,Milano, Mondadori, 1969, pp. 65-81.
***
Frontespizio degli Inni Sacri
edizione del 1824 |
|
 C’è molto di vero nell’affermazione che la base ideale degli Inni è sostanzialmente «democratica», cioè il sugo dei «principii» tolti ai filosofi dell’ ’89. C’è molto di vero nell’affermazione che la base ideale degli Inni è sostanzialmente «democratica», cioè il sugo dei «principii» tolti ai filosofi dell’ ’89.
 Soltanto è più onesto dire che il Manzoni non li «toglie», se mai li ‘ritoglie’ a quei filosofi; ché, essi, li avevano ‘tolti’ da altra fonte ben più universale. Soltanto è più onesto dire che il Manzoni non li «toglie», se mai li ‘ritoglie’ a quei filosofi; ché, essi, li avevano ‘tolti’ da altra fonte ben più universale.
 Con quei «principii» il Manzoni s’era incontrato la prima volta alla Maisonnette, e li aveva vissuti come tali, con la loro marca rivoluzionaria. Ritrovata la Fede, ne sconta l’usufrutto giacobino, e li riporta alla loro genuina sorgente, il Vangelo, da cui un’ingratitudine stolta li aveva distaccati. Paion sue parole; è almeno il suo pensiero, al Fauriel. Quel distacco, il Manzoni riteneva assurdo, ingiurioso; e, parlandone con esatto senso storico e morale, diceva che accettare quei principii umanitari non curandosi dei principii religiosi o, peggio, combattendoli, era come impadronirsi d’una casa, distruggendone le fondamenta. Così, quei sentimenti grandi e nobili che gli ideologi avevano svuotato del loro cielo, con gl’Inni tornano religiosi e santi, pur restando umanissimi, da potersi conciliare con lo spirito nuovo, e d’ogni tempo. Cosa che s’avvalora anche più, accadendo in quel principio di secolo quando tutti — filosofi e statisti — gareggiavano nell’aiutare gli ideali democratici, suggerendo i modi di giungere alla elevazione del popolo, del «terzo stato». Alla soluzione del problema il Manzoni porta il suo contributo mostrando che la carità derivata dal Vangelo e disciplinata nel cattolicesimo era il buon succo da far scorrere negli strati dell’umano consorzio per farne un mondo di uguali. Ed è estremamente istruttivo ricordare che tutti i nostri spiriti migliori del Sette e Ottocento s’incontrano con la Rivoluzione francese e ne usufruiscono, diventandone perfino entusiasti; poi, conosciutala meglio, l’abbandonano. È l’insegnamento dell’Alfieri, del Foscolo, del Monti (se il Monti ha qualcosa da insegnare). È l’insegnamento del Manzoni; che, negli anni più tardi, ci scrisse sopra un saggio, che è di condanna. Con quei «principii» il Manzoni s’era incontrato la prima volta alla Maisonnette, e li aveva vissuti come tali, con la loro marca rivoluzionaria. Ritrovata la Fede, ne sconta l’usufrutto giacobino, e li riporta alla loro genuina sorgente, il Vangelo, da cui un’ingratitudine stolta li aveva distaccati. Paion sue parole; è almeno il suo pensiero, al Fauriel. Quel distacco, il Manzoni riteneva assurdo, ingiurioso; e, parlandone con esatto senso storico e morale, diceva che accettare quei principii umanitari non curandosi dei principii religiosi o, peggio, combattendoli, era come impadronirsi d’una casa, distruggendone le fondamenta. Così, quei sentimenti grandi e nobili che gli ideologi avevano svuotato del loro cielo, con gl’Inni tornano religiosi e santi, pur restando umanissimi, da potersi conciliare con lo spirito nuovo, e d’ogni tempo. Cosa che s’avvalora anche più, accadendo in quel principio di secolo quando tutti — filosofi e statisti — gareggiavano nell’aiutare gli ideali democratici, suggerendo i modi di giungere alla elevazione del popolo, del «terzo stato». Alla soluzione del problema il Manzoni porta il suo contributo mostrando che la carità derivata dal Vangelo e disciplinata nel cattolicesimo era il buon succo da far scorrere negli strati dell’umano consorzio per farne un mondo di uguali. Ed è estremamente istruttivo ricordare che tutti i nostri spiriti migliori del Sette e Ottocento s’incontrano con la Rivoluzione francese e ne usufruiscono, diventandone perfino entusiasti; poi, conosciutala meglio, l’abbandonano. È l’insegnamento dell’Alfieri, del Foscolo, del Monti (se il Monti ha qualcosa da insegnare). È l’insegnamento del Manzoni; che, negli anni più tardi, ci scrisse sopra un saggio, che è di condanna.
 Come potè dire il Carducci che gl’Inni sono schiavi della dogmatica? In giorni avventati quando, con le staffe, pareva perdere la stessa proprietà del linguaggio e confondeva dogmatico con cattolico o addirittura con cristiano, potè dirli così; salvo poi a ricredersi, tornando in calma. Allora, con improvviso intenerimento, vedeva negl’Inni «la dolce carezza d’una donna che ha persuaso, e il puro spettacolo delle gioie domestiche che ha vinto». Con discretissima mano, ci apriva la porta di casa Manzoni; la bella casa dove gli affetti riposano tra una tenera moglie che insieme alla sapienza materna serba un animo verginale, e donna Giulia che bada a santificare la vita con le opere di pietà e di quella carità «che ripara al passato e assicura l’avvenire». Gli Italiani si fermano poco a contemplare il puro spettacolo di questa «famiglia nuova che Milano ha regalato all’Italia». Eppure gl’Inni vanno primamente intesi come il suo poetico vapore: poesie d’amore sbocciate tra il focolare e la mensa. Come potè dire il Carducci che gl’Inni sono schiavi della dogmatica? In giorni avventati quando, con le staffe, pareva perdere la stessa proprietà del linguaggio e confondeva dogmatico con cattolico o addirittura con cristiano, potè dirli così; salvo poi a ricredersi, tornando in calma. Allora, con improvviso intenerimento, vedeva negl’Inni «la dolce carezza d’una donna che ha persuaso, e il puro spettacolo delle gioie domestiche che ha vinto». Con discretissima mano, ci apriva la porta di casa Manzoni; la bella casa dove gli affetti riposano tra una tenera moglie che insieme alla sapienza materna serba un animo verginale, e donna Giulia che bada a santificare la vita con le opere di pietà e di quella carità «che ripara al passato e assicura l’avvenire». Gli Italiani si fermano poco a contemplare il puro spettacolo di questa «famiglia nuova che Milano ha regalato all’Italia». Eppure gl’Inni vanno primamente intesi come il suo poetico vapore: poesie d’amore sbocciate tra il focolare e la mensa.
 Dov’è anche la fisionomia del Manzoni e la sua differenza da Dante. Il quale sente la religione sotto la specie dogmatica e ne parla per definizioni teologicamente esatte. (Dio: «Colui lo cui saver tutto trascende»; il purgatorio: «... qui, per quei di là, molto s’avanza»; la redenzione: «State contenti, umana gente, al quia...»). Come un pontefice già abitato da furore tridentino, la verità cattolica, Dante la corona e mitria. Il Manzoni sente la religione, con minore forza, ma come strumento di elevazione morale: e in questo è la sua modernità. Dante riconosce una gerarchia nelle scienze, e al culmine di esse mette la teologia; il Manzoni ci mette la morale: alto privilegio di sentire la religione, che li fa uguali e diversi: uguali per l’eccellenza dell’arte, diversi per l’esperienza e il temperamento e l’età. È significativo che la stessa Vita Nuova o il romanzo dell’amor giovanile, il Contini l’abbia definito «romanzetto teologico». Ma gli Inni sono un canto alla carità, alla religione intesa come beneficio sociale, e già piegano più verso le «azioni», verso le «scene» che non verso le «verità». Dov’è anche la fisionomia del Manzoni e la sua differenza da Dante. Il quale sente la religione sotto la specie dogmatica e ne parla per definizioni teologicamente esatte. (Dio: «Colui lo cui saver tutto trascende»; il purgatorio: «... qui, per quei di là, molto s’avanza»; la redenzione: «State contenti, umana gente, al quia...»). Come un pontefice già abitato da furore tridentino, la verità cattolica, Dante la corona e mitria. Il Manzoni sente la religione, con minore forza, ma come strumento di elevazione morale: e in questo è la sua modernità. Dante riconosce una gerarchia nelle scienze, e al culmine di esse mette la teologia; il Manzoni ci mette la morale: alto privilegio di sentire la religione, che li fa uguali e diversi: uguali per l’eccellenza dell’arte, diversi per l’esperienza e il temperamento e l’età. È significativo che la stessa Vita Nuova o il romanzo dell’amor giovanile, il Contini l’abbia definito «romanzetto teologico». Ma gli Inni sono un canto alla carità, alla religione intesa come beneficio sociale, e già piegano più verso le «azioni», verso le «scene» che non verso le «verità».
 Non, dunque, vezzeggiamento di materia teologica, come fu imprudentemente affermato; se mai, spettacolo liturgico, che è il visibile parlare della verità religiosa: («Via co’ palii disadorni — lo squallor della viola: — l’oro usato a splender torni: — sacerdote, in bianca stola, — esci ai grandi ministeri...») L’impostazione può anche essere teologica, come nel Natale; ma lo sviluppo è pratico, morale. Il poeta è lieto di descrivere in quadri familiari le vereconde allegrezze e gli umani affetti e gli effetti portati dalla solennità, che dà alla Chiesa alcunché di casalingo e fa della casa una chiesa domestica; sicché il mistero religioso diventa una festa familiare. Pensare a certi inviti conviviali Non, dunque, vezzeggiamento di materia teologica, come fu imprudentemente affermato; se mai, spettacolo liturgico, che è il visibile parlare della verità religiosa: («Via co’ palii disadorni — lo squallor della viola: — l’oro usato a splender torni: — sacerdote, in bianca stola, — esci ai grandi ministeri...») L’impostazione può anche essere teologica, come nel Natale; ma lo sviluppo è pratico, morale. Il poeta è lieto di descrivere in quadri familiari le vereconde allegrezze e gli umani affetti e gli effetti portati dalla solennità, che dà alla Chiesa alcunché di casalingo e fa della casa una chiesa domestica; sicché il mistero religioso diventa una festa familiare. Pensare a certi inviti conviviali
(O fratelli, il santo rito
sol di gaudio oggi ragiona;
oggi è giorno di convito...
ogni mensa abbia i suoi doni,
e il tesor negato al fasto
di superbe imbandigioni,
scorra amico all’umil tetto,
faccia il desco poveretto
più ridente oggi apparir)
|
che richiama ai primi sodalizi cristiani quando ogni cosa mia era tua, e pane e vino avevano sulla mensa un genuino sapore evangelico.
 Trionfalmente mostrerà nel romanzo questo suo genio morale (altra cosa dalle intenzioni moralistiche) ove la religione è tutta sentita come sostanza umana, pratica; supposta — non annullata — la dogmatica. La sola «questione» teologica nel romanzo è quella del voto di Lucia, risolta non teologicamente come nel V del Paradiso, a proposito di Piccarda, ma umanissimamente, tra un «vivo rossore» di Lucia e l’agitazione concentrata d’una «inaspettata speranza». Fin d’ora il poeta è impegnato a scansare il pericolo delle secche teologiche, in cui l’altro — «nullius dogmatis expers» — si caccia a capofitto, con compiacenza rigida, feroce, del complicato e del difficile: «Nella profonda e chiara sussistenza...». Trionfalmente mostrerà nel romanzo questo suo genio morale (altra cosa dalle intenzioni moralistiche) ove la religione è tutta sentita come sostanza umana, pratica; supposta — non annullata — la dogmatica. La sola «questione» teologica nel romanzo è quella del voto di Lucia, risolta non teologicamente come nel V del Paradiso, a proposito di Piccarda, ma umanissimamente, tra un «vivo rossore» di Lucia e l’agitazione concentrata d’una «inaspettata speranza». Fin d’ora il poeta è impegnato a scansare il pericolo delle secche teologiche, in cui l’altro — «nullius dogmatis expers» — si caccia a capofitto, con compiacenza rigida, feroce, del complicato e del difficile: «Nella profonda e chiara sussistenza...».
 E dove, per ragione dell’argomento, qualche residuo di teologia è rimasto, quanto c’è di giansenismo o della tetra dottrina secondo la quale, fin dall’origine, per un tremendo disegno di Dio, la «massa dei reprobi» è distinta dalla «piccola alleanza degli eletti»? Niente. La stessa base «democratica» degl’Inni non ammette eccezioni, privilegi, «crudeli discernimenti»; in ogni inno è puntualmente calata una strofa che allontana ogni sospetto incauto. L’uomo è caduto; ma Dio che l’ha creato, ha continuato ad amarlo, gli allunga la mano per rialzarlo: «All’uom la mano Ei porge...». Sa che «al Regno i miseri — seco il Signor solleva», «che a tutti i figli d’Eva — nel suo dolor pensò». Promesse di speranza, echi di festa in Cielo, pegni di godimenti eterni, lavacro di salute per tutti: «Di tutti quel sacro — santo sangue cancelli l’error». «Pagina hilarescit». E nessuna ha il dubbio di Giansenio. «Spunta il sol de’ giorni santi... — Nel Signor chi si confida — col Signor risorgerà.» E dove, per ragione dell’argomento, qualche residuo di teologia è rimasto, quanto c’è di giansenismo o della tetra dottrina secondo la quale, fin dall’origine, per un tremendo disegno di Dio, la «massa dei reprobi» è distinta dalla «piccola alleanza degli eletti»? Niente. La stessa base «democratica» degl’Inni non ammette eccezioni, privilegi, «crudeli discernimenti»; in ogni inno è puntualmente calata una strofa che allontana ogni sospetto incauto. L’uomo è caduto; ma Dio che l’ha creato, ha continuato ad amarlo, gli allunga la mano per rialzarlo: «All’uom la mano Ei porge...». Sa che «al Regno i miseri — seco il Signor solleva», «che a tutti i figli d’Eva — nel suo dolor pensò». Promesse di speranza, echi di festa in Cielo, pegni di godimenti eterni, lavacro di salute per tutti: «Di tutti quel sacro — santo sangue cancelli l’error». «Pagina hilarescit». E nessuna ha il dubbio di Giansenio. «Spunta il sol de’ giorni santi... — Nel Signor chi si confida — col Signor risorgerà.»
 Nessun turbamento cruenta la sua coscienza, in nessun momento; neanche in principio, quando parve coinvolto nel Règlement consegnato dal giansenista ligure alle sue donne, Giulia ed Enrichetta, che lasciavano Parigi per Brusuglio, la bella villa ereditata dal Conte. Nessun turbamento cruenta la sua coscienza, in nessun momento; neanche in principio, quando parve coinvolto nel Règlement consegnato dal giansenista ligure alle sue donne, Giulia ed Enrichetta, che lasciavano Parigi per Brusuglio, la bella villa ereditata dal Conte.
 Anzi, l’incontro coi giansenisti fu per Alessandro e Enrichetta qualcosa di provvidenziale, rappresentando il ponte di passaggio dalla riva del calvinismo, rigidissimo, alla riva cattolica. Guai per Alessandro, e più per Enrichetta, se, invece che in spiriti rigorosi, si fossero imbattuti in spiriti rilassati, fra tanti che ce n’erano, predicatori e non praticatori della verità cattolica. E se il giansenismo, almeno in un primo tempo, ha un valore nei riguardi del Manzoni, è quello di spiegare al suo animo attento il quadro delle azioni che vanno verso la perfezione; che essi, i giansenisti, avevano poi il torto di corrompere, animandola di disperato orgoglio, mentre in lui funzionò il suo equilibrio che tutto compose armonicamente entro uno spirito così bello, splendido, in pace¹. Anzi, l’incontro coi giansenisti fu per Alessandro e Enrichetta qualcosa di provvidenziale, rappresentando il ponte di passaggio dalla riva del calvinismo, rigidissimo, alla riva cattolica. Guai per Alessandro, e più per Enrichetta, se, invece che in spiriti rigorosi, si fossero imbattuti in spiriti rilassati, fra tanti che ce n’erano, predicatori e non praticatori della verità cattolica. E se il giansenismo, almeno in un primo tempo, ha un valore nei riguardi del Manzoni, è quello di spiegare al suo animo attento il quadro delle azioni che vanno verso la perfezione; che essi, i giansenisti, avevano poi il torto di corrompere, animandola di disperato orgoglio, mentre in lui funzionò il suo equilibrio che tutto compose armonicamente entro uno spirito così bello, splendido, in pace¹.
 S’è insistito sul valore interno degl’Inni, perché qui è la prima novità: nel ritrovamento di questa umana verità. Non direi pari la solidità lirica, che s’alimenta della libertà della lingua, dell’intimità delle immagini, che manca ancora. Però il disegno è di mano larga, esperta, d’uno che sa lavorare gli spazi. Non è poco tentare in un inno — Il Natale — la storia dell’umanità nei suoi rapporti con Dio: argomento da Cantica dantesca. E se poesia è anche passione ritmica, rigore logico, Il Natale rischia, per certe resistenti zone, d’esser gran poesia. L’attacco, che è un concetto teologico liberato in immagine, impegna le prime tre strofe in una animazione pindarica: S’è insistito sul valore interno degl’Inni, perché qui è la prima novità: nel ritrovamento di questa umana verità. Non direi pari la solidità lirica, che s’alimenta della libertà della lingua, dell’intimità delle immagini, che manca ancora. Però il disegno è di mano larga, esperta, d’uno che sa lavorare gli spazi. Non è poco tentare in un inno — Il Natale — la storia dell’umanità nei suoi rapporti con Dio: argomento da Cantica dantesca. E se poesia è anche passione ritmica, rigore logico, Il Natale rischia, per certe resistenti zone, d’esser gran poesia. L’attacco, che è un concetto teologico liberato in immagine, impegna le prime tre strofe in una animazione pindarica:
 Qual masso che dal vertice Qual masso che dal vertice
di lunga erta montana...
|
Basta scuotere dalla memoria gl’illustri settenari, perché intorno si senta la gran lode di Goethe e il collaudo degli anni; ma, soprattutto, che s’intona una musica inseritasi da padrona nell’anima e oramai parte di essa, e diventa pura melodia man mano che si libera dai concetti non sciolti in fantasmi («Tal si giaceva il misero...»), o dalle interrogazioni declamatorie («Qual mai tra i nati all’odio...»), e va verso la creazione delle scene: irraggiamento d’angeli, scampanìo di splendori, e il palpitare della notte:
 E intorno a lui per l’ampia E intorno a lui per l’ampia
notte calati a stuolo
mille celesti strinsero
il fiammeggiante volo...
|
 Il linguaggio crea spazi poetici; «l’ampia notte» è un risultato rapido almeno quanto l’«ampia oscurità» foscoliana, e quei «celesti» che «strinsero il fiammeggiante volo», rendono una robustezza lessicale di angeli danteschi. O è una scaltrita sapienza d’accenti, che fa i versi profondi e profondo il cielo, che ne vibra: Il linguaggio crea spazi poetici; «l’ampia notte» è un risultato rapido almeno quanto l’«ampia oscurità» foscoliana, e quei «celesti» che «strinsero il fiammeggiante volo», rendono una robustezza lessicale di angeli danteschi. O è una scaltrita sapienza d’accenti, che fa i versi profondi e profondo il cielo, che ne vibra:
 L’allegro inno seguirono L’allegro inno seguirono
tornando al firmamento;
tra le varcate nuvole
allontanossi, e lento...
|
 (Anche il Tasso: «S’indorava la notte al divin lume»; ma è decorativo. Manca l’animazione che regge i settenari magnanimi; metro contro il quale il Bontempelli inutilmente solleverà la sua ironia). E l‘innamorata memoria corre sollecita alle varie vaghe bellezze sparse negl’Inni, con l’ansia d’una rallegrante vendemmia. Coglie, frantuma, gode. Ma, ahimè, che queste deliberazioni, questo estrarre e vantare nuclei più ricchi, è già denunzia di altre zone inerti, di cedimenti d’ispirazione che si fa enfatica, o stagna in narrazione neghittosa, in aggettivazione delusa. Vicino a strofe sgorgate, immacolate, ce n’è di gratuite; spunti di felicità piena, si scontano con altri, mortali, morti. E l’«Explicit infeliciter», che il poeta scrisse sotto Il Natale, siamo tentati di scriverlo sotto tutto il libretto. (Anche il Tasso: «S’indorava la notte al divin lume»; ma è decorativo. Manca l’animazione che regge i settenari magnanimi; metro contro il quale il Bontempelli inutilmente solleverà la sua ironia). E l‘innamorata memoria corre sollecita alle varie vaghe bellezze sparse negl’Inni, con l’ansia d’una rallegrante vendemmia. Coglie, frantuma, gode. Ma, ahimè, che queste deliberazioni, questo estrarre e vantare nuclei più ricchi, è già denunzia di altre zone inerti, di cedimenti d’ispirazione che si fa enfatica, o stagna in narrazione neghittosa, in aggettivazione delusa. Vicino a strofe sgorgate, immacolate, ce n’è di gratuite; spunti di felicità piena, si scontano con altri, mortali, morti. E l’«Explicit infeliciter», che il poeta scrisse sotto Il Natale, siamo tentati di scriverlo sotto tutto il libretto.
 Racconta il Tommaseo nei Colloqui col Manzoni che, domandandogli alcuno come avesse fatto a trovare la poesia degli Inni, il Manzoni ripose: «Pensandoci su», che fu sempre il precetto della sua «poetica». E il Tommaseo commenta: «Non intendeva già del pensare a cercar poesia che, cercata, non si trova; ma del pensare i proprii sentimenti e le comuni idee della Chiesa che, pur con l’essere comuni, diventano sentimenti». Chi parla così, è uno che ha conversato col Manzoni e, tornando dai bei colloqui, scriveva quanto ricordava dei discorsi di lui. Il guaio è che, per non averle sempre «pensate» abbastanza, le reminiscenze restano tali, non si fanno sentimento, vita: e liricamente le sentiamo come pesi morti. Pesano sugl’Inni schemi squallidi, ritmi inoperosi, lingua «poetica» cioè impoetica (né individuale né intima) che scomparirà fra poco, innanzi all’uso vivente, quando ogni parola farà come se repirasse². Racconta il Tommaseo nei Colloqui col Manzoni che, domandandogli alcuno come avesse fatto a trovare la poesia degli Inni, il Manzoni ripose: «Pensandoci su», che fu sempre il precetto della sua «poetica». E il Tommaseo commenta: «Non intendeva già del pensare a cercar poesia che, cercata, non si trova; ma del pensare i proprii sentimenti e le comuni idee della Chiesa che, pur con l’essere comuni, diventano sentimenti». Chi parla così, è uno che ha conversato col Manzoni e, tornando dai bei colloqui, scriveva quanto ricordava dei discorsi di lui. Il guaio è che, per non averle sempre «pensate» abbastanza, le reminiscenze restano tali, non si fanno sentimento, vita: e liricamente le sentiamo come pesi morti. Pesano sugl’Inni schemi squallidi, ritmi inoperosi, lingua «poetica» cioè impoetica (né individuale né intima) che scomparirà fra poco, innanzi all’uso vivente, quando ogni parola farà come se repirasse².
 Bossuet e Fénelon gli hanno dato alcune perentorie certezze; per esempio, che la storia è tutta dominata da Dio; non gli hanno ancora dato il gusto della lingua tutta attiva e corrente, della limpidezza espressiva. Gl’Inni rappresentano il primo nuovo del Manzoni, la conversione religiosa; non ancora quella letteraria, che verrà dopo, con la maggior pienezza spirituale; e restano ancora in gran parte più «documento» che poesia. Bossuet e Fénelon gli hanno dato alcune perentorie certezze; per esempio, che la storia è tutta dominata da Dio; non gli hanno ancora dato il gusto della lingua tutta attiva e corrente, della limpidezza espressiva. Gl’Inni rappresentano il primo nuovo del Manzoni, la conversione religiosa; non ancora quella letteraria, che verrà dopo, con la maggior pienezza spirituale; e restano ancora in gran parte più «documento» che poesia.
 Ma provatevi, per un gioco mentale, a sopprimerli dal libro della poesia, e vedrete come essa si fa, d’improvviso, più povera. Gl’Inni hanno creato uno spazio nuovo, e, dando un senso religioso alla vita, l’hanno fatta più ampia, più umana. Ma provatevi, per un gioco mentale, a sopprimerli dal libro della poesia, e vedrete come essa si fa, d’improvviso, più povera. Gl’Inni hanno creato uno spazio nuovo, e, dando un senso religioso alla vita, l’hanno fatta più ampia, più umana.
 Psicologia? Echi di avventure terrene, lontane dai veri interessi dell’arte? Forse; come la questione del suo giansenismo o del suo romanticismo o dell’ideologismo, o di quell’altre che bisognerà un giorno abbandonare definitivamente per liberare il poeta nella sua sola passione — la poesia — e raggiungerlo nel suo vero risultato: la poesia. D’altra parte, è proprio questa biografia che forma la civiltà di un libro; son queste avventure terrene che da cent’anni paiono aumentare le dimensioni del poeta — il suo campo di risonanza — e impegnano in opere vive i più appassionati e provveduti ingegni. Psicologia? Echi di avventure terrene, lontane dai veri interessi dell’arte? Forse; come la questione del suo giansenismo o del suo romanticismo o dell’ideologismo, o di quell’altre che bisognerà un giorno abbandonare definitivamente per liberare il poeta nella sua sola passione — la poesia — e raggiungerlo nel suo vero risultato: la poesia. D’altra parte, è proprio questa biografia che forma la civiltà di un libro; son queste avventure terrene che da cent’anni paiono aumentare le dimensioni del poeta — il suo campo di risonanza — e impegnano in opere vive i più appassionati e provveduti ingegni.
 (Né, nemmeno oggi, alcuno può illudersi di saper tutto di lui, «Latent res eximiae».) (Né, nemmeno oggi, alcuno può illudersi di saper tutto di lui, «Latent res eximiae».)
 Gl’Inni restano, a ogni modo, frammenti di un disegno già smagliato nelle stesse mani del poeta. Scrisse il Carducci: «Spiccò dalle vette dell’evangelo un volo che poi non volle e non potè compiere sì largo come aveva disegnato». E perché invece di dodici, com’era nel piano prima divisato, ne scrisse sol quattro, non lo disse a nessuno, ma ci pare di capirlo. Coscienza alacre fortemente autocritica, in quel genere di poesia in cui doveva pur conseguire originalità e già lo annunciava come il maggior poeta dei suoi anni, trovava disarmonie, possibilità di tradire la semplicità essenziale dei testi, che nella pagina diventavano spesso citazioni gratuite, senza resa lirica: Gl’Inni restano, a ogni modo, frammenti di un disegno già smagliato nelle stesse mani del poeta. Scrisse il Carducci: «Spiccò dalle vette dell’evangelo un volo che poi non volle e non potè compiere sì largo come aveva disegnato». E perché invece di dodici, com’era nel piano prima divisato, ne scrisse sol quattro, non lo disse a nessuno, ma ci pare di capirlo. Coscienza alacre fortemente autocritica, in quel genere di poesia in cui doveva pur conseguire originalità e già lo annunciava come il maggior poeta dei suoi anni, trovava disarmonie, possibilità di tradire la semplicità essenziale dei testi, che nella pagina diventavano spesso citazioni gratuite, senza resa lirica:
 Quando Aggéo, quando Isaia Quando Aggéo, quando Isaia
mallevâro al mondo intero
che il Bramato un dì verrìa...
|
(Ahimè.) O si facevano cantabili, descrittivi, affidati a una evidenza esteriore:
 Un estranio giovinetto Un estranio giovinetto
si posò sul monumento;
era folgore l’aspetto,
era neve il vestimento...
|
 Un Arici, un Borgi potevano contentarsi di questi versi e della loro grazia fallace, non lui. Un Arici, un Borgi potevano contentarsi di questi versi e della loro grazia fallace, non lui.
 E forse è anche vero che, quitatosi «il dolce zelo» del novizio, il Manzoni sospettò scarsa preparazione a trattare quei temi; temette d’esser ancora «in piccioletta barca». Dissipatore nella prima gioventù, non aveva drizzato il collo per tempo «al pan degli Angeli», alla scienza del bene, di cui voleva rappresentare il panorama agli uomini. Tornerà a riprendere il lavoro più tardi, con altra pratica d’arte, altra coscienza di poeta: con altra voce... E nascerà La Pentecoste che, per pienezza spirituale, quasi non ha più parentela coi primi quattro, se non nel «tema» o memoria del disegno. E forse è anche vero che, quitatosi «il dolce zelo» del novizio, il Manzoni sospettò scarsa preparazione a trattare quei temi; temette d’esser ancora «in piccioletta barca». Dissipatore nella prima gioventù, non aveva drizzato il collo per tempo «al pan degli Angeli», alla scienza del bene, di cui voleva rappresentare il panorama agli uomini. Tornerà a riprendere il lavoro più tardi, con altra pratica d’arte, altra coscienza di poeta: con altra voce... E nascerà La Pentecoste che, per pienezza spirituale, quasi non ha più parentela coi primi quattro, se non nel «tema» o memoria del disegno.
***
Autografo de La Pentecoste
Biblioteca Nazionale Braidense, Milano |
|
 La Pentecoste fu vagheggiata e lavorata dal 1817 al 1822³. (Il Leopardi, l’idea del Passero solitario l’ebbe nel 1818, e lo terminò nel 1829). Che La Pentecoste non abbia più nulla a che fare con i primi quattro Inni, s’è già lasciato capire. Qualcuno ora ci aiuta a esprimerci meglio: quelli erano i «temi» e questo è la musica. La Pentecoste fu vagheggiata e lavorata dal 1817 al 1822³. (Il Leopardi, l’idea del Passero solitario l’ebbe nel 1818, e lo terminò nel 1829). Che La Pentecoste non abbia più nulla a che fare con i primi quattro Inni, s’è già lasciato capire. Qualcuno ora ci aiuta a esprimerci meglio: quelli erano i «temi» e questo è la musica.
 La prima grandezza dell’inno si spiega con la grandezza dell’argomento: la verità religiosa si irraggia della virtù della poesia, e la poesia si vivifica degli splendori della verità. Poesia alleata di Dio. Però gente di gusto e di molta pratica d’arte, ancora oggi innanzi alla Pentecoste non è del tutto in pace. Il Falqui, per esempio. La prima grandezza dell’inno si spiega con la grandezza dell’argomento: la verità religiosa si irraggia della virtù della poesia, e la poesia si vivifica degli splendori della verità. Poesia alleata di Dio. Però gente di gusto e di molta pratica d’arte, ancora oggi innanzi alla Pentecoste non è del tutto in pace. Il Falqui, per esempio.
 Tre sospetti gli graverebbero sopra, espressi con riverente cautela, poiché l’inno intimidisce anche i più audaci. Il primo è di un’intenzione apologetica ch’esso conserverebbe. Ma è questione di non lasciarci suggestionare da pregiudizi; in esso il fervore del convertito ha interamente ceduto alla contemplazione dell’artista, offrendo all’inno il caldo che lo fa sbocciare in una profonda fermentazione di poesia. La realtà della Chiesa è sentita con maestà e cordialità: Tre sospetti gli graverebbero sopra, espressi con riverente cautela, poiché l’inno intimidisce anche i più audaci. Il primo è di un’intenzione apologetica ch’esso conserverebbe. Ma è questione di non lasciarci suggestionare da pregiudizi; in esso il fervore del convertito ha interamente ceduto alla contemplazione dell’artista, offrendo all’inno il caldo che lo fa sbocciare in una profonda fermentazione di poesia. La realtà della Chiesa è sentita con maestà e cordialità:
 ...campo di quei che sperano, ...campo di quei che sperano,
Chiesa del Dio vivente;
|
ne è vista pittorescamente l’origine umile, quasi sorgente di fiume destinato a beneficare tutta la terra.
 Ne fa la storia, rendendola con immagini, l’una seme dell’altra, che creano quadri: il suo svilupparsi, il suo spiegarsi faticoso nel mondo: Ne fa la storia, rendendola con immagini, l’una seme dell’altra, che creano quadri: il suo svilupparsi, il suo spiegarsi faticoso nel mondo:
Tu che, da tanti secoli,
soffri, combatti e preghi;
che le tue tende spieghi
dall’uno all’altro mar;...
|
 Il motivo della sua vittoria fiorisce nello Spirito che discende sopra di lei, e si fa luce, si fa voce: Il motivo della sua vittoria fiorisce nello Spirito che discende sopra di lei, e si fa luce, si fa voce:
 Come la luce rapida Come la luce rapida
piove di cosa in cosa,
e i color vari suscita
dovunque si riposa;
tal risonò molteplice
la voce dello Spiro:...
|
Spirito di libertà, d’uguaglianza universale, voluta dalla forza morale e sociale del Cristianesimo. Ne esce un mondo nuovo, spaziante:
 Nova franchigia annunciano Nova franchigia annunciano
I Cieli, e genti nove...
|
 Naturalmente ne segue un suo valore apologetico; perché la persuasione cattolica d’un uomo come il Manzoni ha un suo inevitabile peso nella esperienza religiosa. Sarà anche più vero coi Promessi sposi; come lo è per La Divina Commedia. Ed è certo gran cosa che la verità cattolica abbia avuto celebratori in Dante e in Manzoni, le due vette della poesia italiana. Ma altra cosa è il «valore» apologetico in cui sentiamo l’inno, altra «l’intenzione apologetica», che nell’inno non c’è. O meglio: se mai intenzione moralistica era nella mente del poeta, attraverso la potenza della fantasia e della mente commossa, s’è prostrata e sciolta in poesia. Il gran contenuto è liberato nell’arte. Naturalmente ne segue un suo valore apologetico; perché la persuasione cattolica d’un uomo come il Manzoni ha un suo inevitabile peso nella esperienza religiosa. Sarà anche più vero coi Promessi sposi; come lo è per La Divina Commedia. Ed è certo gran cosa che la verità cattolica abbia avuto celebratori in Dante e in Manzoni, le due vette della poesia italiana. Ma altra cosa è il «valore» apologetico in cui sentiamo l’inno, altra «l’intenzione apologetica», che nell’inno non c’è. O meglio: se mai intenzione moralistica era nella mente del poeta, attraverso la potenza della fantasia e della mente commossa, s’è prostrata e sciolta in poesia. Il gran contenuto è liberato nell’arte.
 L’altro sospetto è quello d’uno spirito oratorio in cui l’inno sarebbe concepito. E chissà come abbiamo potuto confondere una piena e commossa intonazione corale con un «flusso oratorio». Il suo slancio maestoso non è strepito oratorio ma pienezza di canto. E cosa vuol dire quella distinzione tra slancio di poesia e slancio di preghiera? e che quello è arte e questo no? Rinnegheremo cumuli luminosi della nostra tradizione, e Iacopone e gran parte del Paradiso. C’è, da un po’ di tempo, una immite crociata contro la «rettorica», e vogliono dire eloquenza. Nel fervore delle parole, temiamo si scambino per «rettorica» certi valori assoluti della nostra grande arte solo perché non coincidono con qualche nostra esigenza personale, forse più tormentata che vera. L’altro sospetto è quello d’uno spirito oratorio in cui l’inno sarebbe concepito. E chissà come abbiamo potuto confondere una piena e commossa intonazione corale con un «flusso oratorio». Il suo slancio maestoso non è strepito oratorio ma pienezza di canto. E cosa vuol dire quella distinzione tra slancio di poesia e slancio di preghiera? e che quello è arte e questo no? Rinnegheremo cumuli luminosi della nostra tradizione, e Iacopone e gran parte del Paradiso. C’è, da un po’ di tempo, una immite crociata contro la «rettorica», e vogliono dire eloquenza. Nel fervore delle parole, temiamo si scambino per «rettorica» certi valori assoluti della nostra grande arte solo perché non coincidono con qualche nostra esigenza personale, forse più tormentata che vera.
 Ammettiamo che a una sensibilità espertissima come la nostra, possa ingenerare fastidio certa frequente animazione di interrogazioni («Dov’eri mai? qual angolo ti raccogliea nascente?» «Figlia immortal, dov’eri?» «Perché baciando i pargoli...?» «Non sa che al Regno i miseri...?») o pochi ritmi inoperosi («E sia divina ai vinti — mercede il vincitor» — «Se fuso a lui nell’etere...»). Ma non basta per dichiarare l’inno inficiato di «oratoria». Se mai, sono ragnateli sotto le arcate solenni. Ammettiamo che a una sensibilità espertissima come la nostra, possa ingenerare fastidio certa frequente animazione di interrogazioni («Dov’eri mai? qual angolo ti raccogliea nascente?» «Figlia immortal, dov’eri?» «Perché baciando i pargoli...?» «Non sa che al Regno i miseri...?») o pochi ritmi inoperosi («E sia divina ai vinti — mercede il vincitor» — «Se fuso a lui nell’etere...»). Ma non basta per dichiarare l’inno inficiato di «oratoria». Se mai, sono ragnateli sotto le arcate solenni.
 Terza accusa, una cotale incertezza lessicale o, insomma, una scarsa freschezza linguistica. Qui particolarmente ci turba il ricordo d’esserci un giorno scandalizzati in non so che arcaismi (algenti, altor, pondo, ètere, ascoso, virtude, ecc.). Non ci accorgemmo che il poeta adopra vocaboli che hanno il colore degli anni d’una volta, per adombrarvi la delicatezza di certi misteri: Terza accusa, una cotale incertezza lessicale o, insomma, una scarsa freschezza linguistica. Qui particolarmente ci turba il ricordo d’esserci un giorno scandalizzati in non so che arcaismi (algenti, altor, pondo, ètere, ascoso, virtude, ecc.). Non ci accorgemmo che il poeta adopra vocaboli che hanno il colore degli anni d’una volta, per adombrarvi la delicatezza di certi misteri:
spose, che desta il subito
balzar del pondo ascoso;...
|
che anche questo pudore è suggestivo elemento di poesia.
 Ma sarebbe deplorevole condannare un capolavoro solo per qualche apostrofe che ci ostiniamo a chiamare oratoria, o per la presenza di sei o sette voci antiche (e diciamo pure antiquate) che, alla fine, furono primamente pronunciate dalla sacra bocca di Dante, e dunque sempre vitali. Ma sarebbe deplorevole condannare un capolavoro solo per qualche apostrofe che ci ostiniamo a chiamare oratoria, o per la presenza di sei o sette voci antiche (e diciamo pure antiquate) che, alla fine, furono primamente pronunciate dalla sacra bocca di Dante, e dunque sempre vitali.
 Parlando della Pentecoste disse un giorno il Manzoni ch’era quanto di meglio gli fosse uscito in fatto di poesia. Pensava al molteplice mondo che muove e allarga la prospettiva dell’inno, ed era già il «suo» mondo. Ma anche l’arte ha raggiunta la sua sommità poiché il poeta ha interamente conquistato il suo tema. Il poeta può dire tutto quello che vuole, sicuro di dirlo bene; la materia più trepida gli diviene docilissima, i concetti s’alleggeriscono in immagini; gli accenni arditi son resi con vereconda eleganza: Parlando della Pentecoste disse un giorno il Manzoni ch’era quanto di meglio gli fosse uscito in fatto di poesia. Pensava al molteplice mondo che muove e allarga la prospettiva dell’inno, ed era già il «suo» mondo. Ma anche l’arte ha raggiunta la sua sommità poiché il poeta ha interamente conquistato il suo tema. Il poeta può dire tutto quello che vuole, sicuro di dirlo bene; la materia più trepida gli diviene docilissima, i concetti s’alleggeriscono in immagini; gli accenni arditi son resi con vereconda eleganza:
voi già vicine a sciogliere
il grembo doloroso;...
|
 Anche le derivazioni sono meno palesi, dalla Bibbia o dal suo Virgilio; e, se qualcosa riprende, lo fa con tal garbo d’elaborazione da parere piuttosto ri-creazione o accrescimento di poesia. Nel continuo controllo di sé, il Manzoni ora è tutto «sull’orma propria». Ci è giunto attraverso l’acquisto di un linguaggio che dipinge le anime (l’«ineffabile» riso dei fanciulli, la «casta porpora» delle donzelle, il «verecondo amore» della sposa, «le pure gioie ascose» delle vergini ecc.): il linguaggio morale. Anche le derivazioni sono meno palesi, dalla Bibbia o dal suo Virgilio; e, se qualcosa riprende, lo fa con tal garbo d’elaborazione da parere piuttosto ri-creazione o accrescimento di poesia. Nel continuo controllo di sé, il Manzoni ora è tutto «sull’orma propria». Ci è giunto attraverso l’acquisto di un linguaggio che dipinge le anime (l’«ineffabile» riso dei fanciulli, la «casta porpora» delle donzelle, il «verecondo amore» della sposa, «le pure gioie ascose» delle vergini ecc.): il linguaggio morale.
 La capacità acquistata con gl’Inni di scendere dal divino all’umano, gli permette ora il cammino a ritroso: salire dall’umano al divino, che è il movimento seguìto nella lirica civile e patriottica, e nei cori. La capacità acquistata con gl’Inni di scendere dal divino all’umano, gli permette ora il cammino a ritroso: salire dall’umano al divino, che è il movimento seguìto nella lirica civile e patriottica, e nei cori.
***
Frontespizio de Il Cinque Maggio
edizione del 1832 |
|
 Poca ma valente, la lirica civile è rappresentata dal Cinque maggio, il cantico «che forse non morrà»; anche se nella mente dei lettori vive con un’impressione di barocco agevolmente ironizzabile: tanto può sopra un capolavoro anche una menda di stile in età espertissima e scaltrita. Poca ma valente, la lirica civile è rappresentata dal Cinque maggio, il cantico «che forse non morrà»; anche se nella mente dei lettori vive con un’impressione di barocco agevolmente ironizzabile: tanto può sopra un capolavoro anche una menda di stile in età espertissima e scaltrita.
 A intonarlo, s’ha l’impressione di riscuotere certe agitate musiche di Verdi (l’altro genio della stirpe), grandioso nel disegno e squillante, cosa tutta italiana e di tutti, tanto è nell’aria. A intonarlo, s’ha l’impressione di riscuotere certe agitate musiche di Verdi (l’altro genio della stirpe), grandioso nel disegno e squillante, cosa tutta italiana e di tutti, tanto è nell’aria.
 Scritto a Brusuglio tra il 19 luglio e il 21 — «tre giorni di convulsione», in cui il poeta, ad aiutare l’estro e l’invasamento, obbligò Enrichetta vicina ad ammalarsi per la sesta volta, a stare al cembalo, scavando i tasti disperatamente — l’inno tiene di quella concitazione procellosa, a cui forse si deve un meno di finitezza rispetto ad altri; ma per vastità di visione, sta bene presso La Pentecoste. Uscito anch’esso, e più degli altri, dalla religiosa contemplazione di Bossuet e Fénelon, che Dio guida la storia, Napoleone vi appare non solo come una vasta «orma di piè mortale», ma come «più vasta orma dello spirito creatore di lui», Dio, il suo esaltatore e il suo vincitore vero. Perciò la figura ha proporzioni gigantesche quasi di disegno provvidenziale. «Surgit divini aliquid...» che rompe i limiti brevi dell’uomo, sparge spazi, allarga prospettive, e tutto trasporta nel dominio di Dio. Scritto a Brusuglio tra il 19 luglio e il 21 — «tre giorni di convulsione», in cui il poeta, ad aiutare l’estro e l’invasamento, obbligò Enrichetta vicina ad ammalarsi per la sesta volta, a stare al cembalo, scavando i tasti disperatamente — l’inno tiene di quella concitazione procellosa, a cui forse si deve un meno di finitezza rispetto ad altri; ma per vastità di visione, sta bene presso La Pentecoste. Uscito anch’esso, e più degli altri, dalla religiosa contemplazione di Bossuet e Fénelon, che Dio guida la storia, Napoleone vi appare non solo come una vasta «orma di piè mortale», ma come «più vasta orma dello spirito creatore di lui», Dio, il suo esaltatore e il suo vincitore vero. Perciò la figura ha proporzioni gigantesche quasi di disegno provvidenziale. «Surgit divini aliquid...» che rompe i limiti brevi dell’uomo, sparge spazi, allarga prospettive, e tutto trasporta nel dominio di Dio.
 «Fu vera gloria?» Se anche lo fu in mezzo agli uomini, nel giro corto del tempo, non è più nulla nei «campi eterni... dov’è silenzio e tenebre — la gloria che passò». Sbigottiti versi che paiono tradurre Pascal: «Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie». Ma non s’intenda nel senso giansenistico, del silenzio di Dio. I versi che immediatamente precedono, son lì apposta a escluderlo: sopra il tentativo di disperazione, piove la pietà divina: «Fu vera gloria?» Se anche lo fu in mezzo agli uomini, nel giro corto del tempo, non è più nulla nei «campi eterni... dov’è silenzio e tenebre — la gloria che passò». Sbigottiti versi che paiono tradurre Pascal: «Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie». Ma non s’intenda nel senso giansenistico, del silenzio di Dio. I versi che immediatamente precedono, son lì apposta a escluderlo: sopra il tentativo di disperazione, piove la pietà divina:
 Ahi! forse a tanto strazio Ahi! forse a tanto strazio
cadde lo spirto anelo,
e disperò; ma valida
venne una man dal Cielo,
e in più spirabil aere
pietosa il trasportò;
 e l’avviò, pei floridi e l’avviò, pei floridi
sentier della speranza,
ai campi eterni, al premio,
che i desideri avanza,...
|
 Si è potuto anche sorridere su quel «venne una man dal Cielo»: ma ben chiaro è il significato della espressione. Il Manzoni che non ebbe mai simpatia per il violento, ora la sente. La sua «vera gloria» comincia con l’ultima ora, quando, spento il rumore del mondo e abbandonato dagli uomini, Dio gli scende vicino e, come fa, lo consola. Ha deposto il potente dal trono e, fattolo umile, lo esalta. Si è potuto anche sorridere su quel «venne una man dal Cielo»: ma ben chiaro è il significato della espressione. Il Manzoni che non ebbe mai simpatia per il violento, ora la sente. La sua «vera gloria» comincia con l’ultima ora, quando, spento il rumore del mondo e abbandonato dagli uomini, Dio gli scende vicino e, come fa, lo consola. Ha deposto il potente dal trono e, fattolo umile, lo esalta.
 La storia, cospirazione divina nei fatti umani, non ha mai avuto in poesia un’interpretazione religiosa così strenua come in quest’epica in settenari: incalzanti, balenanti di immagini maestose: La storia, cospirazione divina nei fatti umani, non ha mai avuto in poesia un’interpretazione religiosa così strenua come in quest’epica in settenari: incalzanti, balenanti di immagini maestose:
 Come sul capo al naufrago Come sul capo al naufrago
l’onda s’avvolse e pesa,...
|
d’espressioni fulminee:
 Dall’Alpi alle Piramidi, Dall’Alpi alle Piramidi,
dal Manzanarre al Reno,
di quel securo il fulmine
tenea dietro al baleno;...
|
(vien naturale un confronto con la veloce terzina del VI del Paradiso: «Quel che fe’ poi ch’elli uscì da Ravenna — e saltò Rubicon, fu di tal volo — che nol seguiteria lingua né penna»); di evocazioni malinconiche:
Oh quante volte al tacito...
|
di rappresentazioni concitate
E ripensò le mobili / tende...
|
 Poi la «cruenta polvere» la «terra attonita» (la «adtonita civitas» di sant’Agostino?), «la spoglia immemore», «la procellosa e trepida gioia...», «il giorno inerte», «le stanche ceneri» e altri nuclei, che aiutano la densità lirica dell’ode. Poche poesie dànno impressione di resa più colma, d’un crescere a vista d’occhio, a ogni svoltar di strofa, d’uno sbocco sull’infinito. Poi la «cruenta polvere» la «terra attonita» (la «adtonita civitas» di sant’Agostino?), «la spoglia immemore», «la procellosa e trepida gioia...», «il giorno inerte», «le stanche ceneri» e altri nuclei, che aiutano la densità lirica dell’ode. Poche poesie dànno impressione di resa più colma, d’un crescere a vista d’occhio, a ogni svoltar di strofa, d’uno sbocco sull’infinito.
 S’è detto che nell’inno sono elementi «barocchi», cioè di stile meno puro e quasi canzonevole: da quell’«orma del piede», anzi del «piè» (ma quell’«orma» morde la polvere; il Manzoni l’aveva già detto di sé: «l’orma propria») alla «mano che scende dal Cielo» (e non ha nulla a vedere con «la mano del cielo» del capitolo XXV del romanzo, o la «mutatio dexterae Excelsi» del XXIII), dai «due secoli l’un contro l’altro armato» a Napoleone che «si asside in mezzo a loro». Spiega perché l’inno, visto contro luce, poté prestarsi alla parodia. Né diremo poesia questo ragionamento: «Fu vera gloria? Ai posteri — l’ardua sentenza...». È, piuttosto, un apprezzamento col quale dovran fare i conti gli storici. Chi cerca la poesia, la trova altrove: nel «lampo dei manipoli», nell’«onda dei cavalli», nel «concitato imperio», e nel «celere obbedir». Ma il Cinque maggio per altezza di meditazione, per volo di fantasia, vastità di prospettive e spazio di magnanime immagini, verrebbe voglia di dirla la lirica sovrana del poeta. S’è detto che nell’inno sono elementi «barocchi», cioè di stile meno puro e quasi canzonevole: da quell’«orma del piede», anzi del «piè» (ma quell’«orma» morde la polvere; il Manzoni l’aveva già detto di sé: «l’orma propria») alla «mano che scende dal Cielo» (e non ha nulla a vedere con «la mano del cielo» del capitolo XXV del romanzo, o la «mutatio dexterae Excelsi» del XXIII), dai «due secoli l’un contro l’altro armato» a Napoleone che «si asside in mezzo a loro». Spiega perché l’inno, visto contro luce, poté prestarsi alla parodia. Né diremo poesia questo ragionamento: «Fu vera gloria? Ai posteri — l’ardua sentenza...». È, piuttosto, un apprezzamento col quale dovran fare i conti gli storici. Chi cerca la poesia, la trova altrove: nel «lampo dei manipoli», nell’«onda dei cavalli», nel «concitato imperio», e nel «celere obbedir». Ma il Cinque maggio per altezza di meditazione, per volo di fantasia, vastità di prospettive e spazio di magnanime immagini, verrebbe voglia di dirla la lirica sovrana del poeta.
 Affinità di situazioni tra il Cinque maggio e il coro dell’Ermengarda, ci sono, e non solo esteriori. Un re e una regina sbalzati dal trono nella polvere; confinati, Napoleone a Sant’Elena a meditare sul suo passato («stette, e dei dì che furono — l’assalse il sovvenir»), Ermengarda in un chiostro di Brescia a meditare sul tempo che fu («sempre al pensier tornavano — gl’irrevocati dì»). Lui, a rimpianger la gloria che scolorisce come l’erba; lei, la felicità che mentisce come il cuore. Dalle «stanche ceneri» del primo, il poeta invoca che si «sperda ogni ria parola»; «alle incolpate ceneri» dell’altra, assicura che «nessuno insulterà». L’uno scompare avendo accanto «sulla deserta còltrice» «il Dio che atterra e suscita»; l’altra, mentre lo sente venire: «Parlatemi di Dio, sento ch’Ei giunge». E se nel Cinque maggio c’era la verità che anche i più grandi non sono nulla innanzi a Dio, nel di là, Affinità di situazioni tra il Cinque maggio e il coro dell’Ermengarda, ci sono, e non solo esteriori. Un re e una regina sbalzati dal trono nella polvere; confinati, Napoleone a Sant’Elena a meditare sul suo passato («stette, e dei dì che furono — l’assalse il sovvenir»), Ermengarda in un chiostro di Brescia a meditare sul tempo che fu («sempre al pensier tornavano — gl’irrevocati dì»). Lui, a rimpianger la gloria che scolorisce come l’erba; lei, la felicità che mentisce come il cuore. Dalle «stanche ceneri» del primo, il poeta invoca che si «sperda ogni ria parola»; «alle incolpate ceneri» dell’altra, assicura che «nessuno insulterà». L’uno scompare avendo accanto «sulla deserta còltrice» «il Dio che atterra e suscita»; l’altra, mentre lo sente venire: «Parlatemi di Dio, sento ch’Ei giunge». E se nel Cinque maggio c’era la verità che anche i più grandi non sono nulla innanzi a Dio, nel di là,
ov’è silenzio e tenebre
la gloria che passò...
|
nell’Ermengarda si va più oltre, c’è una più delicata esplorazione nelle ragioni della verità morale e del sentimento, cioè che anche gli umili — e i potenti scesi al livello degli umili — e gli oppressi, diventano grandi portati sulla scala di Dio. È l’umana e cristiana fragranza di questa poesia, ed è ormai l’idea fissa del poeta: gli ultimi saranno i primi, e chi sa diventar ultimo. Questo, che è il sugo del coro e del dramma, è il dono della sventura; «provvida», se Dio nella sua logica sovrumana sa cavare il bene anche dal male. Sono le situazioni del Carmagnola, dell’Adelchi; e l’Innominato. Anch’essi tornano umili, e nell’umiltà ritrovano le più consolanti evidenze.
 Tutto questo può farci pensare a una esigenza del poeta: spargere conforto, poiché l’ha trovato per sé. E può anche darsi che nella realtà del dramma questo diventi un punctum dolens; ma indubbiamente costituisce una ricchezza personale dell’autore e una rivelazione dell’anima sua, che ci interessa non meno della sua arte. Tutto questo può farci pensare a una esigenza del poeta: spargere conforto, poiché l’ha trovato per sé. E può anche darsi che nella realtà del dramma questo diventi un punctum dolens; ma indubbiamente costituisce una ricchezza personale dell’autore e una rivelazione dell’anima sua, che ci interessa non meno della sua arte.
 Lasciò scritto il Carducci che «a ogni nuovo canto il Manzoni acquistava d’arte». Pensava all’Ermengarda, finita di scrivere l’ottobre del 1822, l’anno che moriva il Canova, e il poeta compiva i trentasette. Lasciò scritto il Carducci che «a ogni nuovo canto il Manzoni acquistava d’arte». Pensava all’Ermengarda, finita di scrivere l’ottobre del 1822, l’anno che moriva il Canova, e il poeta compiva i trentasette.
 L’Ermengarda è la sua lirica migliore; per il decoro della misura, per versi inventati in gara coi più gemmati e trepidi dell’Ottocento; del Leopardi, che sentì più nitidi e men caldi: L’Ermengarda è la sua lirica migliore; per il decoro della misura, per versi inventati in gara coi più gemmati e trepidi dell’Ottocento; del Leopardi, che sentì più nitidi e men caldi:
...Così
dalle squarciate nuvole
si svolge il sol cadente,
e, dietro il monte, imporpora
il trepido occidente:
al pio colono augurio
di più sereno dì.
|
 Anche il linguaggio che è lo strumento cospicuo del poeta (lo strumento che solum è suo) e ne segna e segue lo splendente salire, qui s’è fatto ridentemente nuovo, senza peso, dipinto: un’ilare ressa di «invenzioni», culminando in quel «trepido occidente», che non l’ha nemmeno il Foscolo. «Hic omnia rident». Anche il linguaggio che è lo strumento cospicuo del poeta (lo strumento che solum è suo) e ne segna e segue lo splendente salire, qui s’è fatto ridentemente nuovo, senza peso, dipinto: un’ilare ressa di «invenzioni», culminando in quel «trepido occidente», che non l’ha nemmeno il Foscolo. «Hic omnia rident».
 Ma la rima è una festa che vuol esser scontata; esigentissima, vuol storpiature di parole, rinuncia a un discorso più libero; quindi a un pubblico più vasto. Ed è oramai vicino lo sbocco definitivo della lirica nella prosa; attuazione perfetta di convincimenti linguistici estetici morali, maturi nel 1822; l’anno che il Manzoni — con questo coro — scrive l’ultima poesia in versi dove, raggiunto il riposo del suo stile lirico, se ne stacca, delicatamente, per sempre. Ma la rima è una festa che vuol esser scontata; esigentissima, vuol storpiature di parole, rinuncia a un discorso più libero; quindi a un pubblico più vasto. Ed è oramai vicino lo sbocco definitivo della lirica nella prosa; attuazione perfetta di convincimenti linguistici estetici morali, maturi nel 1822; l’anno che il Manzoni — con questo coro — scrive l’ultima poesia in versi dove, raggiunto il riposo del suo stile lirico, se ne stacca, delicatamente, per sempre.
 Quando da un poggio aereo, Quando da un poggio aereo,
il biondo crin gemmata...
|
 La visione, uscita dall’alto, arricchisce per sempre il mondo delle forme. Non è più lieve il velo delle Grazie, e il loro fiore d’argento. E l’aver raggiunto questo alleggerimento, questo creato incanto, gli dà il diritto di staccarsene, delicatamente, per sempre. La visione, uscita dall’alto, arricchisce per sempre il mondo delle forme. Non è più lieve il velo delle Grazie, e il loro fiore d’argento. E l’aver raggiunto questo alleggerimento, questo creato incanto, gli dà il diritto di staccarsene, delicatamente, per sempre.
1. Influenza giansenista nel Manzoni, dunque, ci fu: ma in bene. Gli fece sentire che la vita è cosa seria, e magari severa. Corrispondeva puntualmente al suo temperamento, alle sue esigenze morali. Quel «più» che nel giansenismo traboccava in eresia, egli lo temperò col suo sapiente equilibrio, con il suo «intimo senso» delle cose cattoliche. Sicché, partito dal giansenismo, giunse al cattolicesimo integrale e vi restò. La sua adesione alla eresia, è cosa che abbiamo inventata noi, dopo; o certo esagerata, come ha fatto il Ruffini, nel suo furore consequenziario di neofita.
2. Qualcuno (qualche mistico) si scandalizza di taluna espressione degl’Inni, certamente materialotta; per esempio, che è nel Natale, «grave di tal portato»; e intanto esalta Dante e la sua validità lessicale. Non ricordando che il «portato» è proprio di Dante, è proprio in quel senso e in quell’uso: «Povera fosti tanto — quanto veder si può per quello ospizio — ove sponesti il tuo portato santo» (Purgatorio, c. XX, vv. 22-24). E anche Leopardi, nel titolo d’una canzone pochissimo nota: Nello strazio di una giovane fatta trucidare col suo portato.
3. Su questa faticosa formazione, lavorò con appassionatissima attenzione Ireneo Sanesi, il più diligente studioso del Manzoni («Annali manzoniani», 1943). L’edizione della Pentecoste è del 1855. Il Firpo, nella Strenna Utet 1962, ci presenta i vari rifacimenti dell’inno e la loro tormentosa redazione.
***
Autografo del Cinque Maggio
Biblioteca Nazionale Braidense, Milano |
|
***
|